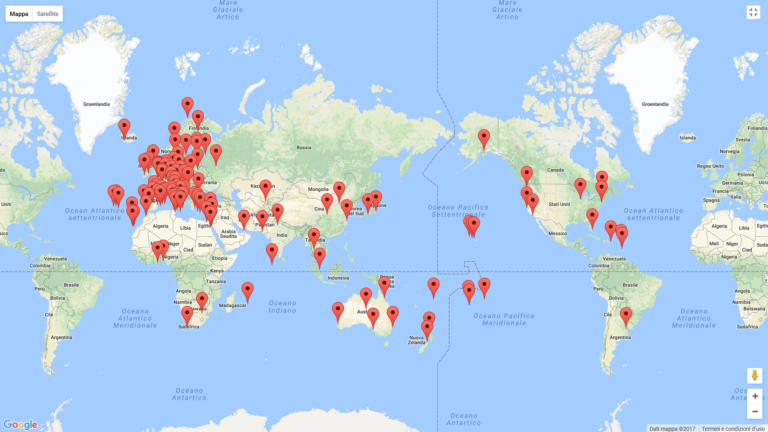Il giorno della tesi



Quando il direttore di facoltà, uomo insignificante di cui non ricordo neppure il nome, in quel 23 settembre di 20 anni addietro, mi nominò Dottore in Medicina e Chirurgia, mi sentii profondamente deluso che non avessero aggiunto la lode al voto pieno e tondo.
Caspita! Me la meritavo tutta. Non ero assolutamente stato lì a calcolare con la precisione matematica come fanno tutti gli studenti, in un procedimento laborioso in cui, a momenti, dovevi incrociare il tuo peso con il segno zodiacale. Per dio, avevo una buona media, superiore al 27.
Certo fisiologia me l’aveva abbassata di brutto, ma con il professore Ventura, il superamento dell’esame era diventato una cosa personale, così avevo accettato un voto misero al terzo tentativo; ma era anche colpa di quel gran bastardo di ginecologia, tronfio e arrogante; sicuramente poteva permetterselo: bello, biondo e occhi cerulei; era ovvio che tutte gliela facessero vedere!
Avevo, soprattutto, discusso una tesi sperimentale nientedimeno che sul trapianto di piccolo intestino. Mi ero messo a studiare tutta la casistica del Pittsburgh Transplantation Institute.
In quel giorno con gli occhi socchiusi, mi ero focalizzato sul numero agognato, centodieci, monco però di quell’apposizione, che avrebbe concluso felicemente il mio personale curriculum universitario. Non avevo sentito altro. Avevo subito guardato il mio relatore, il prof. di chirurgia per eccellenza, verso il quale provavo un’ammirazione viscerale, dissoltasi immediatamente dopo quel proclama, e lui, per tutta risposta, si era girato dall’altra parte, sentendosi in colpa per non aver voluto premiare anche me. Mi ero poi voltato verso gli altri due, ormai, colleghi: loro, la lode, se la erano conquistata. Sembrava volessero dire: povero cristo, vedi che sei un cretino.
Era il giorno del diluvio, in un settembre che di colpo aveva spalancato le porte all’inverno. Infatti, prima di quello, il cielo era bello, terso, memorabile. Un intero mese senza rovinose perturbazioni.
L’estate si era dileguata in un attimo. Ero molto rammaricato che il sole non mi facesse compagnia. Anzi, in quel 23 di settembre, era tutto buio. Per di più, nello scalone che porta alla biblioteca, stavano girando lo spot del Kinder Bueno, sì, quello mi “vuoi tutta ciccia e brufoli?”
Le telecamere, soprattutto i fari alogeni, conferivano un’aria surreale a quel cortile. Anche il Volta, impietrito nella sua posa seriosa da almeno un paio di secoli, sembrava preoccupato per quel dileggio.
Mi accorsi, finalmente, di mia madre, e, dopo di lei, di tutti i miei parenti. Mi chiedevo perché fossero venuti, non mi immaginavo che la laurea potesse essere considerata alla stregua di un matrimonio. Tutti che si complimentavano con me, mentre mi schioccavano baci sulle guance, uno per lato. Io, invece, avrei voluto mandarli tutti a quel paese.
Non ero ancora del tutto consapevole ma d’ora in avanti avrei dovuto fare il medico. E l’idea mi spaventava. Avevo semplicemente frequentato l’università per il solo piacere dello studio, mai avrei pensato che quella era un tramite per proiettarsi nel mondo del lavoro e nella vita adulta. Mi piaceva la medicina, non la dedizione per la sofferenza degli uomini. Avrei studiato fino allo sfinimento tutti i recessi del corpo, ma da quel momento in poi sarei dovuto diventare protagonista.
Quel mio io non era ancora pronto per la nuova vita, anzi non ne aveva consapevolezza. Quell’Io che non aveva ancora elaborato il concetto della vera medicina. Trovavo insopportabile indossare il camice bianco, e temevo gli interminabili e puzzolenti corridoi del San Matteo.
Proprio quel me stesso che di fronte al paziente, al quarto anno, non era capace di formulare una diagnosi nemmeno quali esami prescrivere. Mi ero ritrovato questo vecchietto edentulo, odore di urina, piedi varicosi e una flebo al braccio.
Oppure di fronte alla bambina, in neuropsichiatria infantile, che aveva tentato di accoltellare un altro coetaneo, mi ero spaventato perché non sapevo che cosa risponderle e come trattarla.
Avevo visto la prima autopsia, un cadavere, morto di pancreatite: dovevi avere del coraggio per discernere le strutture anatomiche ormai sovvertite dagli enzimi, prima ancora di vomitare dallo schifo.
No, io non facevo parte del mondo reale. Volevo seppellirmi alla Bonetta, la biblioteca nella quale passavo interi pomeriggi a leggere e a studiare. Non volevo avere a che fare con gli esseri viventi.
Anche se non ci avevo capito molto, rimpiangevo il tempo passato sul microscopio a guardare vetrini per la tesi di laurea. Leggevo The puzzle people di Starzl, a cui avrebbero dedicato il centro trapianti. Ecco, così, mi sentivo un uomo senza identità, un po’ fantasioso, coi pezzettini d’organo ricomposti dopo un trapianto.
A proposito di trapianti, quanti: aprivi, toglievi tutto quello che c’era da togliere, e richiudevi. Non un contatto con l’anima delle persone. Rimanevo nel mio ordine di idee, nel mio piccolissimo microcosmo.
Dovevo risolvere ancora tanti affanni e mettere pezze per non deragliare di nuovo. Il tempo passato senza consapevolezza e amore verso se stessi, avrei potuto benissimo buttarlo via nel cestino. E, infatti, i ricordi universitari sono quelli più bui e scabrosi, inconfessabili. Non mi riferisco al tempo impiegato per studiare, ne utilizzavo davvero tanto con diligenza, con impegno e cura. Ero in competizione con persone più mediocri di me, riconoscendo invece il merito ad altre più acute e metodiche. Con il ragazzo di Novara, studiavo a lungo, ininterrottamente, giorno e notte. Lui si spremeva le meningi, faceva la fatica di sfrondare le mille parole inutili dei testi universitari. Io lo ascoltavo, riuscivo a interpretare il succo e ne facevo una sintesi impeccabile. Il gioco sporco lo faceva lui, io apprendevo e bevevo il nettare di quanto colava dalle sue labbra. Presi 30 in anatomia, lui, 28 e mi dispiacque moltissimo perché se lo meritava tutto, il volto più alto. Con il B., occhiali spessi come fondi di bottiglia, brutto come la fame, non ero per nulla in competizione.
Il buio, invece, non voglio ricordarlo e neanche sfioralo. Qualcosa di vago, sì: i silenzi nel quadrilatero del collegio, i pianti tra le braccia di Flavia, i viaggi di andata e ritorno per le capitali europee. Il resto è il nero, cacciato nel fondo e negli antri junghiani più problematici del mio essere.
La passione per i libri era insanziabile, li annusavo, li mettevo sotto il cuscino dormendoci sopra. L’ottimismo era un inesauribile desiderio di conoscere. Frequentavo tutte le lezioni, ascoltavo con commozione e spirito attivo le parole dei cattedratici più o meno illuminati. Sento ancora la fragranza di mirabili lezioni. Quando mi si svelava un mondo, di cui riuscivo a cogliere l’essenza e a farlo mio, sentivo di raggiungere la catarsi. Ecco perché ero arrabbiato con il Ventura. La fisiologia me l’aveva fatta scoprire in modo così cristallino e immediatamente percepibile.
Eppure… Eppure… Ma ciò faceva parte del mio essere ancora immaturo e incompleto, non ancora adulto, non ancora del tutto ferito. Sarebbe bastato poco, ma avevo tanto di quel tempo avanti per rendermene conto.
Così i sei anni si consolidarono in quel giorno di 20 anni fa, rimanendo rappreso come un grumo, come un qualcosa di fastidioso. Non ero ancora riuscito a realizzare di aver superato il gradino della laurea, che già dovevo festeggiare con tutti loro, i parenti, che da secoli non vedevo. Mi ero tolta quella fastidiosa sensazione provata per la discussione della tesi. Ero assonnato, stanco. Il prof. di chirurgia aveva voluto che rimanessi in sala operatoria fino alle tre del pomeriggio, praticamente, appena un’ora prima del dibattito. Se fosse stato per lui, avrei dovuto aspettare altri due anni per la laurea e, forse, per la lode.
Ero distrutto dalla preparazione del materiale: intere notti a raccogliere e a sintetizzare numeri su numeri. E pensare che la statistica era per me una cosa astrusa, eppure con tutti quei numeri avrei dovuto estrarre un qualcosa, grazie al chi quadrato, al doppio cieco randomizzato e a tante altre metodiche da paroloni altisonanti; la ricerca doveva avere un senso esprimibile in una dissertazione, scritta possibilmente in un italiano corretto e senza errori ortografici.
Ma ero sfinito anche da tutto il resto: sentivo sotto le narici l’odore di maiale, del sangue ragrumato, dei farmaci, dello stabulario.
Ero sporco, nonostante la doccia.
Pensavo a quella dedica, messa in prima pagina, voluta fortemente dal responsabile della ricerca, un medicuccio che sembrava fosse uscito dal film “La febbre del sabato sera” per quei pantaloni oscenamente attillati, di bianco. Mi chiedevo chi fosse quel Jeffrey A. vagante per le strade di New York, intercettato poi in quelle della più briosa cittadina della Pennsylvania.
Un povero pezzente però, grazie alla sua miseria, il mondo era riuscito in un’impresa unica ed avanzava di un passo verso il trapianto di intestino, perché durante un gioco sporco di droga, si era beccato una pallottola che gli aveva reciso la mesenterica superiore. C’era stato bisogno di un negro, spacciatore, immunodepresso e forse infettato dal virus dell’Aids perché la scienza fosse glorificata.
Non mi restavano impressi i dati delle innumerevoli tabelle. Avevo aperto semplicemente il libro rosso della tesi e elencato tutte le statistiche.
Poveri maiali: avevano segni di rigetto con reazioni infiammatorie a livello della sottomucosa e linfoadenopatie. Li avevo classificati a seconda del responso del vetrino e alla durata di sopravvivenza che non andava oltre il mese. Era tutta una questione di merda: se era diarrea allora c’erano rigetto e malassorbimento, altrimenti, se stronzi ben formati, beh, si poteva pensare che il dosaggio del farmaco fosse quello giusto.
In fondo l’immunodepressivo su cui si focalizzava l’attenzione di università di mezzo mondo, l’FK506, era talmente così innovativo che da lì a poco il Ministero alla Sanità, lo avrebbe approvato. D’altronde a Parigi, pochi giorni dopo, avrei incontrato la signora sul Bateaux Mouche, affittato dalla società scientifica per la cena di gala, con il nuovo intestino e una faccia terrea. Moribonda, direi, ma tutta lustrini; un filo di perle dello stesso colore dell’incarnato, sorreggeva quella pelle incartapecorita modellata da mesi di ciclosporina e, soprattutto, di tracolimus, nome di certo più suggestivo di quello della sua sigla.
E finivo di parlare, quasi accasciandomi sul tavolo, esausto, non per la stanchezza ma per il mio equilibrio interno. Cosa avrei dovuto fare, era un grande mistero. Ecco perché volevo la lode, non per questione di prestigio, ma per farmi perdonare tutto il resto che non ho voluto e potuto raccontare qui. Per un riscatto. Incredibilmente, mia madre lo aveva capito proprio all’atto della proclamazione.
Quella madre… che aveva sempre ignorato i miei desideri. Eppure per una frazione di secondo metteva da parte tutti i sogni di cui si era sempre alimentata: avere un figlio medico. Era riuscita a immaginare la mia infelicità e il baratro sul quale mi stavo esponendo. Dai miei occhi tristi aveva capito che non mi interessava la carriera, la competizione e tutto il resto. Avevo tanti di quei psicodrammi da riallineare e da riportare sui giusti binari. In altre parole ero ancora lontano mille miglia dall’essere adulto, per essere, di conseguenza, un buon medico consapevole.
Mi sentivo strattonare, c’era chi mi stringeva le mani mentre con le mie trattenevo quel volume in tela rossa con il logo dell’università di Pavia. Ma io volevo scappare dal salone delle Lauree, dal cortile di Volta, percorrere Strada Nuova e allontanarmi per sempre dalle sponde lungo le quali scorreva il Ticino e dall’ospedale la cui grandezza non mi era sembrata così enorme prima di allora.
Invece no: dovevo ingurgitare la torta, i pasticcini, stare con la nonna, e distribuire confetti rossi e bomboniere neanche dovessi sposarmi. Ricominciare il cammino verso una nuova realtà e ambizioni che si sarebbero presto infrante pochi anni dopo al porto di Boston, dopo essere partito da quello meno prosaico di Livorno. Gli anni della chirurgia che si sarebbero seguiti a ritmo serrato in sedute estenuanti in sala operatoria tra Pavia e Como.
Ecco il giorno della tesi.
Superstar – Lupe Fiasco
If you are what you say you are
A super star
Then have no fear the camera’s here and the microphone and they wanna know
Oh oh oh oh
If you are what you say you are
A super star
Then have no fear the crowd is here and the lights are on and they want a show
Oh oh oh ohYea, uh
A fresh cool young Lu
Trying to cash his microphone check 2, 1, 2
Want to believe my own hype but it’s too untrue
The world brought me to my knees
What have you brung you
Did you improve on the design
Did you do something new
Well your name ain’t on the guest list
Who brung you, you
The more famous person you come through
And the sexy lady next to you
You come to
And then it hit me
Standing outside of heaven waiting for god to come and get me
I’m too uncouth
Unschooled to the rules
And two gum shoe
Too much of a newcomer
And too uncool
Like Shadow and Lavelle
I battle with it well
Though I need a holiday like lady who song blue
Go back what ever you did you undo
Heavy is heaven
The devil on my two tons tooIf you are what you say you are
A super star
Then have no fear the camera’s here and the microphone and they wanna know
Oh oh oh ohAnd you better wear your shades
The spotlights here can burn holes through the stage
Down through the basement
Passed the Indian graves
Where the dinosaurs laid
And out through china
Nearly misses air liners
Magnified times five
This is pointed at the rhymer
Ricochets off the moon and sets the forest a blaze
Now that’s important to say
Cause even with all of that
Most of us don’t want it to fade
We want it to braid
Meaning we want it to grow
Meaning we want it to stay
Like the governor called
And they told him to wait
Un-strap him from the chair
And put him back in his cage
The audience ain’t fazed
And they ain’t gone clap and they ain’t gone praise
They want everything back that they paid
Cause they been waiting since ten to see the lights get dimIf you are what you say you are
A super star
Then have no fear the camera’s here and the microphone and they wanna know
Oh oh oh ohSo chauffeur chauffeur come and take me away
Cause I been standing in this line
For like five whole days
Me and security ain’t getting along
And when I got to the front they told me all of the tickets were gone
So just take me home where the mood is mellow
And the roses are thrown
M&M’s are yellow
And the light bulbs around my mirror don’t flicker
Everybody gets a nice autograph picture
One for you and one for your sister
Who had to work tonight but is an avid listener
Every songs a favorite song
And mikes don’t feed back
All the reviewers say you need to go and see that
And everybody claps cause everybody is pleased
Then they all take the stage and start performing for me
Like ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha haIf you are what you say you are
A super star
Then have no fear the camera’s here and the microphone and they wanna know
Oh oh oh oh
If you are what you say you are
A super star
Then have no fear the crowd is here and the lights are on and they want a show
Oh oh oh oh
If you are what you say you are (yeah, yeah) a superstar (gon’ say now)
Then have no fear, the camera’s here
And the microphones
And they wanna know-oh-oh-oh, yeah (free Chilly)
Yeah, uh, a fresh cool young Lu’
Tryin’ cash his microphone check, 2-1-2
Wanna believe my own hype but it’s too untrue
The world brought me to my knees, what have you brung you?
Did you improve on the design? Did you do somethin’ new?
Well, your name ain’t on the guest list, who brung you?
You! The more famous person you come through
And the sexy lady next to you, you come too
And then it hit me
Standin’ outside of heaven waitin’ for God to come and get me
I’m too uncouth
Unschooled to the rules and too gum shoe
Too much of a new comer and too un-cool
Like Shadow and Lavelle, I battle with it well
Though I need holiday like lady who sung “Blue”
Go back, whatever you did you undo
Heavy as heaven, the devil on me, two tons too
If you are what you say you are, a superstar
Then have no fear, the camera’s here
And the microphones
And they wanna know-oh-oh-oh, yeah
And you better wear your shades
The spotlights here can burn holes through the stage
Down to the basement pass the Indian graves
Where the dinosaurs laid and
Out through China, nearly miss the airliners
Magnified times five, ‘less it’s pointed at the rhymer
Ricochets off the moon and sets the forest ablaze
Now, that’s important to say
‘Cause even with all that most of us don’t want it to fade
We want it to braid, meaning we want it to grow
Meaning we want it to stay
Like the governor called and he told him to wait
Unstrap him from the chair and put him back in his cage
The audience ain’t fazed
And they ain’t gon’ clap and they ain’t gon’ praise
They want everything back that they’ve paid
‘Cause they’ve been waitin’ since ten to see the lights get dim
If you are what you say you are, a superstar
Then have no fear, the crowd is here
And the lights are on
And they want a show-oh-oh-oh, yeah
So chauffeur, chauffeur, come and take me away
‘Cause I’ve been standin’ in this line for like five whole days
Me and security ain’t getting’ along
And when I got to the front, they told me all of the tickets were gone
So just take me home where the mood is mellow
And the roses are grown, M&M’s are yellow
And the light bulbs around my mirror don’t flicker
Everybody gets a nice autograph picture
One for you and one for your sister
Who had to work tonight but is an avid listener
Every songs her favorite song and mics don’t feedback
All the reviewers say “You need to go and see that”
And everybody claps ‘cause everybody is pleased
And then they all take the stage and start performin’ for me
Like, “Ha, ha, ha-ha-ha”
“Ha, ha, ha-ha-ha, ha”
If you are what you say you are, a superstar
Then have no fear, the camera’s here
And the microphones
And they wanna know-oh-oh-oh (yeah)
If you are
What you say you are
Then have no fear